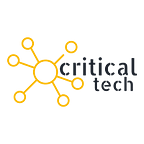The social dilemma
Un documentario schietto che parla di temi spinosi in modo digeribile. Riuscirà a portare il cambiamento che vorrebbe?
Il documentario “The Social Dilemma”, prodotto e distribuito da Netflix, ha infiammato il dibattito online e offline e generato recensioni lungo un ampio spettro, dalle lodi appassionate alle accuse di sensazionalismo e catastrofismo.
Quel che è certo è che ha fatto molto rumore e innescato una riflessione collettiva sull’utilizzo dei social, portando il dibattito nei media mainstream e nelle conversazioni quotidiane.
Durante tutto il mese di settembre “The Social Dilemma” è stato infatti in cima alla classifica statunitense di Netflix, dove la piattaforma di streaming ha 73 milioni di utenti. Naturalmente l’enorme diffusione è stata aiutata dal fatto che Netflix, giovandosi degli stessi meccanismi che il documentario espone, ne ha potuto garantire il prime time algoritmico; senz’altro ha aiutato il passaparola anche la narrazione che il regista Jeff Orlowski ha scelto per il film, che punta sull’emotività degli spettatori oltre che sul loro senso critico.
La scommessa di Orlowski sull’emotività dell’audience risulta particolarmente evidente nella scelta di intervallare le tante interviste a esperti e insider della Silicon Valley alla rappresentazione romanzata di una famiglia americana i cui tre figli sono influenzati in modi diversi — ma tutti drammatici — dai social media che utilizzano.
Un altro aspetto da sottolineare e che potrebbe aver contribuito al successo del film è che i documentari di critica sociale e politica sono in genere “alternativi” anche nella sceneggiatura e nello stile delle immagini, che potrebbe denotarli come adatti a un’audience di opposizione e allontanare un pubblico di massa (si pensi ai documentari di Micheal Moore, a “We are Legion”, a “The Great Hack”); “The Social Dilemma” al contrario ha una sceneggiatura più classica (interviste frontali e una fiction che ricorda una sit-com) e una fotografia patinata che riesce a impacchettare contenuti e affermazioni di rottura in un prodotto digeribile anche da audience più conservatrici.
Per intenderci, considerazioni sul potere del mezzo televisivo a parte, se “The Social Dilemma” fosse stato un libro invece che un film probabilmente sarebbe comparso solo sugli scaffali di chi già si interessava al tema e non avrebbe sconfinato nel mainstream.
Affermazioni da verificare
Discutendo con colleghi che si occupano di tecnologia mi sono stupita di quanto i messaggi a mio parere più estremi del documentario non fossero stati giudicati come particolarmente degni di nota.
Ad esempio Jonathan Haidt, uno degli esperti intervistati, mostra in un clip come negli Stati Uniti, dal 2010–2011, il tasso di autolesionismo tra le adolescenti sia salito del 62%, del 189% tra le preadolescenti. Fatto ancora più tragico, aumenti simili si siano riscontrati per i suicidi nelle stesse fasce d’età. Questi sono dati statistici e in quanto tali obiettivi (almeno sulla carta); non è obiettiva però la causa che lo psicologo sociale individua per spiegare il trend, ovvero la diffusione degli smartphone e la conseguente onnipresenza delle app social, affermazione fatta con sicurezza eccessiva.
Correlazione e rapporto di causalità sono due cose ben diverse: una volta individuata una correlazione anche robusta dal punto di vista statistico è necessario indagare ulteriormente per dimostrare che, oltre a muoversi assieme, due fenomeni siano uno causa dell’altro. Il professor Haidt, essendo un accademico, avrà questo concetto senz’altro ben presente, ma o ha deciso di non approfondire davanti alle telecamere i motivi per cui i social media senza ombra di dubbio abbiano portato all’aumento dei suicidi, o è stato “tagliato” in fase di montaggio, oppure ha usato i dati in modo opportunistico per spingere una sua tesi. Niente di nuovo, ma è doveroso sottolinearlo.
Dissidenti in giacca e cravatta
A parte la presenza di esperti come il prof. Haidt e di altri noti critici della Silicon Valley come l’eclettico Jaron Lanier, autore di Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social, e Shoshana Zuboff, autrice di “ Il capitalismo della sorveglianza “, la forza del documentario è quella di presentare opinioni di insider illustri, persone che hanno partecipato e, in molti casi, continuano a partecipare pienamente al sistema pur mettendone in discussione le stesse premesse.
Tristan Harris, figura centrale e promotore di “The Social Dilemma”, è un programmatore di successo e ha lavorato come etico del design per Google. Ora è uno dei cofondatori del Center for Humane Technology, centro di ricerca e divulgazione per un uso consapevole della tecnologia.
Forse proprio l’ascendente di Harris, che era riuscito a smuovere la coscienza degli impiegati di Google qualche anno prima con questa coraggiosa presentazione, ha permesso al documentario di assicurarsi i contributi di professionisti, imprenditori e investitori che hanno costruito in prima persona i meccanismi sotto accusa. Tra gli altri Tim Kendall, ex-responsabile della monetizzazione per Facebook; Justin Rosenstein, co-inventore del bottone “Mi piace”; e Roger McNamee, uno tra i primi investitori di Facebook.
Ci sono anche grandi assenti, ad esempio i due co-fondatori di Instagram e il fondatore di WhatsApp, che hanno lasciato Facebook alcuni anni dopo le acquisizioni delle rispettive startup non certo in buoni rapporti. Si pensi ad Acton di WhatsApp che ha finanziato il servizio concorrente di messaggistica sicura Signal e supportato il movimento #deletefacebook dopo l’uscita dall’azienda.
Un sistema sbagliato
La cosa più apprezzabile degli interventi degli insider è la loro schiettezza. La parola “capitalismo” non viene mai pronunciata, ma quello che viene messo in discussione è, se non il capitalismo stesso, la sua versione sregolata e anabolizzata nata nella Silicon Valley. Insomma, si parla di soldi senza giri di parole.
Roger McNamee dice qualcosa di quasi sovversivo per un venture capitalist quando afferma che “ci sono momenti storici in cui gli interessi delle persone, degli utenti, sono più importanti dei profitti di qualcuno che è già miliardario”.
E viene finalmente individuato anche il vero colpevole che spinge l’ormai famigerato manipolo di “giovani uomini bianchi” a trovare sotterfugi algoritmici per tenerci incollati ai nostri schermi. “È il modello di business ad avere un problema”, dice Joe Toscano, ex-Google e autore di “Automating Humanity”. “Non ci sono incentivi fiscali perché queste aziende cambino, ed è per questo che abbiamo bisogno di regolamentazione”. Toscano propone di tassare le aziende in base al possesso di dati, in modo da disincentivarle ad andare a caccia “di ogni singolo dato al mondo”.
Di nuovo, un imprenditore statunitense che invoca più tasse e regolamentazione non è cosa di tutti i giorni. Tristan Harris poi rincara parlando di “un gruppo di persone intrappolate da un modello di business, da incentivi economici e dalla pressione degli azionisti, condizioni che rendono quasi impossibile fare qualunque altra cosa”.
E poi c’è Alex Roetter, ex responsabile del dipartimento software di Twitter, la cui opinione sulle possibilità di cambiamento realisticamente attuabili è chiara ma pessimista: “Potremmo chiudere i servizi, distruggere miliardi di valore per gli azionisti e affrontare cause legali, ma in pratica non puoi rimettere il genio nella lampada. Possiamo fare degli aggiustamenti, ma alla fine quello che le aziende devono fare è aumentare i profitti e l’utilizzo, trimestre dopo trimestre. Più grande diventa, più difficile diventa per chiunque cambiare [il sistema]”.
Le esternalità del tech
L’appello più accorato e più politico, ancora più politico del dissidente Jaron Lanier che in fondo accetta che il mondo sia mosso soprattutto da incentivi economici, è quello di Rosenstein, l’ingegnere del “mi piace”.
Rosenstein non lo esplicita, ma sta parlando di esternalità, ovvero le conseguenze indirette e non volute del commercio o della produzione sull’ambiente e/o sulla società.
“Viviamo in un mondo in cui un albero ha più valore finanziario da morto che da vivo, in cui una balena vale di più da morta che da viva”. E chiude cupamente: “[adesso] siamo noi a essere più profittevoli per un’azienda se passiamo il nostro tempo a fissare uno schermo, a fissare un annuncio pubblicitario, che se lo passiamo vivendo la nostra vita in modo arricchente”.
Critiche/1: “L’avevano già detto altri”
Una delle critiche che è stata mossa al documentario è di non aver tenuto conto dell’impegno, dell’attivismo e del lavoro di ricerca di persone dedicate a contrastare lo strapotere dei social media fin dagli albori di queste tecnologie. Per sottolineare il punto, Mozilla ha stilato una lista di ricerche, libri, leader che da anni suonano il campanello d’allarme e a cui “The Social Dilemma” non ha dato voce.
Certo il lavoro fatto da Orlowski non è completamente originale e le affermazioni degli intervistati, primo fra tutti Harris, peccano di un certo egocentrismo, soprattutto quando espongono come novità dirompenti concetti già trattati in tutto il mondo, in accademia e altrove.
Ad esempio, un altro recente documentario sulla nostra dipendenza dagli schermi e in generale sull’impatto della tecnologia digitale è Stare into the lights, my pretties (2017) dell’australiano Jordan Brown. Il documentario, accessibile gratuitamente, presenta filmati e testimonianze raccolte dal regista lungo un arco di dieci anni ed è stato girato e prodotto senza fondi e senza scopo di lucro. Nonostante ospiti altrettanto illustri (Eli Pariser, che ha definito la filter bubble; Sherry Turkle, accademica e divulgatrice di successo sui temi della tecnologia; Nicholas Carr, altro scrittore di best seller, e molti altri) il documentario di Jordan non ha la cifra stilistica adatta per diventare mainstream, né tantomeno il suo canale di distribuzione.
Tuttavia questo non dovrebbe distogliere dal fatto più importante: la conversazione è iniziata ed è finalmente uscita dalle “torri d’avorio” per raggiungere anche quelli tra noi che non sono ricercatori, programmatori o politici radicali.
Critiche/2: “Dipende da come si usano”
Un altro filone di critiche punta sulla responsabilità personale di ognuno di noi. Starebbe ai singoli utenti destreggiarsi tra gli algoritmi, ricontrollare le notizie e cercare fonti alternative, non farsi influenzare dal numero di Like ricevuti, costruire un’immagine di sé solida in modo da non essere sopraffatti dagli standard di bellezza imposti da influencer e filtri Instagram.
Certo una società fatta di individui con tale capacità critica, così istruiti e allerta è auspicabile. La storia però ci dice che, nei casi in cui fenomeni di massa prendono il sopravvento, sono solo poche le persone ad andare controcorrente e sperare che questo cambi radicalmente ora sa più di illusione che di ottimismo.
In questo senso l’appello di Harris che spinge, da una parte, a responsabilizzare i decisori delle aziende, dall’altra, a una più stretta regolamentazione da parte delle istituzioni, è l’approccio potenzialmente più efficace.
Cosa c’è nel futuro
Uno degli aspetti più interessanti del documentario è il fatto che sia collegato a un’iniziativa concreta, il Center for Humane Technology citato sopra. Il sito raccoglie proposte pragmatiche dirette sia ai singoli, che agli educatori, che — cosa anche più rilevante — alla politica. Nella sezione dedicata ai policymakers si trovano suggerimenti per potenziali riforme politiche volte a eliminare quattro fondamentali asimmetrie individuate da Shoshana Zuboff ne “Il capitalismo della sorveglianza” che le aziende tecnologiche utilizzerebbero contro le società democratiche: asimmetrie informative e di conoscenza, asimmetrie di potere e controllo, asimmetrie di grandezza e scala e asimmetrie di risorse.
Il team di Harris passa poi a individuare otto temi (tra cui privacy, protezione dell’infanzia, responsabilità delle aziende, giustizia fiscale) per i quali raccoglie idee di riforma e legislazioni e regolamentazioni già presenti.
Se l’impulso scatenato da Harris conserverà la sua forza sembrerebbe lecito sperare che il potere degli attori coinvolti possa avere un impatto effettivo. Indipendentemente da questo, negli ultimi mesi abbiamo già assistito all’interrogazione parlamentare degli amministratori delegati di Apple, Google, Facebook e Amazon; inoltre da poche settimane è partita la causa contro Google dell’Antitrust, e da pochi giorni in via preliminare anche l’antitrust UE si è attivato, accusando Amazon di concorrenza sleale.
Originally published at http://criticaltech.it on October 5, 2020.