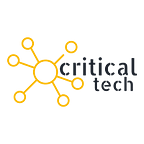I social media “fanno male”, ma non lasciamoli per questo
Ricerche scientifiche fanno a gara per dimostrare i danni neurologici provocati dall’uso delle piattaforme digitali, ma ci sono motivi ben più interessanti per allontanarsene
Ho partecipato di recente alla presentazione “Teaching the Social Dilemma”, organizzata dal Center for Humane Technology. Mi sono iscritta all’evento perché era diretto in particolare agli educatori e prometteva di condividere clip propedeutici alla discussione con gli studenti, più brevi e digeribili del docu-fiction Social Dilemma.
Nonostante gli evidenti limiti del film — è prodotto da Netflix, ha tralasciato fonti da molti ritenute fondamentali, ha un atteggiamento che si può definire candido a voler essere benevoli, colpevolmente arrogante se ci si è svegliati di cattivo umore, lascia spazio ad affermazioni frettolose — ne ho difeso l’approccio pragmatico e il fatto che abbia sollevato questioni di cui si parla ancora poco, come il ruolo del venture capital nell’evoluzione delle startup digitali. Dopo aver partecipato all’evento ho scoperto però di avere una visione meno caritatevole o forse più obiettiva sull’approccio e le istanze portate avanti dall’associazione statunitense.
Meditiamo?
All’inizio dell’evento, condotto da tre esperti legati all’associazione, una nota dissonante: il conduttore annuncia senza la minima autoironia che il suono di un gong proveniente dal suo smartphone (e da dove, altrimenti?) scandirà l’inizio e la fine di una breve meditazione mindfulness. Gli esperti, spalla a spalla ognuno nel suo rettangolo video, chiudono diligentemente gli occhi, e gli astanti più critici sono lasciati alla contemplazione di tre coppie di palpebre chiuse e al dubbio: quanto durerà? Full disclosure: non ho nulla contro la meditazione e la mindfulness, che cerco anzi di praticare tutti i giorni; ho invece una diffidenza istintiva per qualunque tipo di intrusione forzata di un tema importante come la spiritualità in un contesto professionale. L’incipit mi maldispone, ma cerco di rimanere obiettiva e attendo la visione dei clip educativi promessi dagli organizzatori.
Medicalizzazione delle “vittime”
I clip trasmessi sono incentrati sui danni neurologici procurati dall’utilizzo delle piattaforme social: i social rendono dipendenti, diminuiscono la capacità di apprendimento, disperdono l’attenzione, aumentano ansia e depressione, fanno andare male a scuola, diminuiscono la creatività, contribuiscono all’insonnia e la più generica e spaventosa: “cambiano il cervello”. Certo è un passo avanti rispetto all’atteggiamento individualista di chi vorrebbe i singoli pienamente responsabili delle loro scelte, e per queste biasimevoli, ignorando il ruolo delle aziende che investono centinaia di milioni per influenzare le stesse scelte (atteggiamento incidentalmente della stessa marca di quello che vorrebbe ognuno pienamente e individualmente responsabile per il proprio destino ignorando il ruolo della società).
Vedo però almeno un paio di grossi pericoli nell’incentrare la conversazione, soprattutto con ragazze e ragazzi, sui danni neurologici causati dal digitale e per così dire “medicalizzare” il loro rapporto con la tecnologia. Prima di tutto, se utilizzare le piattaforme fa davvero così male e se la società ha così tanto a cuore il benessere dei più giovani, una prima domanda legittima potrebbe essere: allora perché è legale? Evidentemente, come avviene per il tabacco, l’alcol e il gioco d’azzardo considerazioni sui danni causati dall’utilizzo, ben documentati a livello scientifico, non sono sufficienti per annullarne i benefici su qualche altro piano. Già questa semplice domanda apre quindi voragini di contraddizioni da cui anche i più coraggiosi distolgono lo sguardo.
In secondo luogo, l’approccio medico-scientifico adottato per scoraggiare l’utilizzo di social media e altre piattaforme è poco stabile, risultando fortemente soggetto ai capricci e alle volontà di chi divulga i risultati delle ricerche; ricerche che esse stesse possono essere sbugiardate, in un senso o nell’altro, in breve tempo, soprattutto perché si parla di risultati sfuggenti, difficili da monitorare, mutevoli, checché se ne dica. Insomma, se oggi uscisse un nuovo studio da qualche prestigiosa università che cambiasse le carte in tavola, dimostrando gli effetti benefici dell’utilizzo dei social, come reagirebbero i media? Come reagiremmo noi?
Senza dimenticare l’amara ironia di essere costantemente bombardati da messaggi sull’importanza della libertà individuale, salvo poi non poterla esercitare né in un senso, perché manipolati dagli algoritmi, né nell’altro, perché strattonati dalle équipe di ricercatori.
Ma il «Non farlo che ti fa male» ha un terzo peccato, forse il peggiore: è l’approccio meno interessante e stimolante perché soffoca la discussione e l’esercizio del pensiero critico, che, anche se scomodo, può risultare sorprendentemente divertente. Per esempio, se guardiamo alla nostra rete di relazioni, possiamo decidere di non utilizzare i social media non perché fanno male, ma perché preferiamo avere interazioni più intenzionali. O perché siamo francamente annoiati o magari persino infastiditi dalla costante autopromozione dei nostri amici. Magari anche solo per sfida, per testare la nostra individualità, per anticonformismo. Oppure possiamo fare un passo in più e considerare che, una volta assicuratasi la gestione di quasi tutti i nostri bisogni materiali le aziende sono partite alla conquista del nostro territorio emotivo e relazionale, e possiamo decidere di non considerare questo sviluppo necessario né inevitabile.
Su questo ultimo punto forse commetto una fallacia logica se pretendo di distinguere in modo egoistico una tecnologia dall’altra, eppure non mi sembra impossibile immaginare un mondo in cui esistono gli antibiotici, i treni e un sistema di fognature (per dire) ma non dobbiamo subappaltare a piattaforme terze la gestione della nostra vita sociale ed emotiva.
Spremuta o Coca Light?
Il sentimento che sembra prendere sempre più piede, specialmente a partire dal secondo dopoguerra, è quello del “farsi da soli”, dell’auto-aiuto, dell’auto-promozione, dell’auto-miglioramento (Adam Curtis ha detto, sintetizzando, del self); e l’individuo isolato è preda facile del mercato, di cui ha bisogno per la mera sopravvivenza fisica e ora sociale. Il rapporto di simbiosi tra aziende e consumatori è utilitaristico in una direzione, mutevole nell’altra. Ma soprattutto sono le aziende che, nel parafrasare, sedurre, competere, convincere, fanno quello che Kant definirebbe come una negazione de facto della libertà degli individui, considerati non come fini in sé, ma come mezzi — per l’acquisizione di denaro, potere e market share.
Manipolando la relazione con i suoi utenti e mentendo sui suoi obiettivi un social media come Facebook (e come tutti gli altri) ci sta mancando di rispetto e negando la nostra libertà; la stessa cosa fanno le aziende che per aggirare l’obiettivamente complicata legge europea sulla privacy antepongono la lettura e “firma” di interminabili contratti tecnici per farci dare quello che in gergo legale è un consenso, ma in verità è un atto di resa e frustrazione.
L’ultima domanda, non retorica, è: cosa stanno facendo i volenterosi promotori del Center for Humane Technology? Stanno proponendo una rivoluzione del modo di pensare e di stare insieme, o meramente giocattoli diversi per intrattenerci in modo un po’ meno dannoso? Insomma, sono la spremuta d’arancia o la Coca Cola Light?